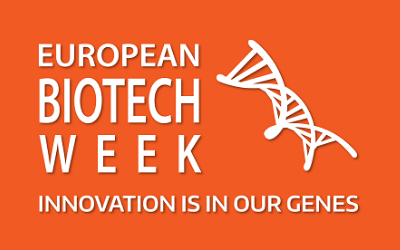News
Editing genomico per eliminare il virus dell'herpes simplex
Uno studio statunitense è riuscito a debellare il 90% del virus in modelli animali. La strategia si basa su meganucleasi e apre le porte ad un approccio curativo per una delle infezioni più comuni
Chi ha detto che le terapie geniche possono essere utili solo per curare gravi malattie genetiche rare? Secondo uno studio pubblicato lo scorso 18 agosto su Nature Communications, potrebbe essere efficace anche per combattere l’Herpes simplex virus (HSV), noto principalmente come herpes labiale, con cui una buona parte della popolazione ha avuto – e continua, essendo un’infezione permanente – ad avere a che fare. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2016, infatti, ben il 67% della popolazione mondiale di età inferiore ai 50 anni, con punte fino al 88% in Africa, ha il virus Herpes simplex di tipo 1 (HSV-1).
- Di: Cristina Tognaccini
Digital health, la tecnologia wearable al servizio del cuore
Com’è cambiata la gestione delle malattie cardiache con la pandemia? Una panoramica sul tema in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore che, come ogni anno, si celebrerà il 29 settembre
La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto su molti aspetti della nostra vita tra cui anche la gestione delle patologie cardiache. Le persone sono diventate più caute nel visitare gli ospedali, specialmente nel periodo di emergenza, e le visite mediche saltate o rimandate hanno avuto importanti conseguenze, a volte anche fatali. Uno studio italiano pubblicato a giugno sull’European Heart Journal ha evidenziato una notevole riduzione - circa del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 - delle ospedalizzazioni in Italia per infarto acuto del miocardio con un aumento dei tassi di complicazioni e mortalità. La telemedicina e gli strumenti di digital health potrebbero rivoluzionare la gestione delle patologie cardiache in situazione di emergenza ma anche, e soprattutto, in condizioni di normalità.
- Di: Rachele Mazzaracca
Terapia cellulare, un altro premio all’eccellenza italiana
Graziella Pellegrini: “I riconoscimenti fanno piacere, ma la parte importante è quello che si fa. Servono motivazione, passione e predisposizione per dedicarsi alla ricerca”
La prof.ssa Graziella Pellegrini - professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita, co-fondatrice e direttrice della Ricerca e Sviluppo dello spin-off universitario Holostem Terapie Avanzate e coordinatrice della terapia cellulare al Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia - ha recentemente vinto l’European Tech Women Awards. Riconoscimento promosso dal Department for International Trade britannico e annunciato durante l’apertura della London Tech Week, che si è svolta dall’1 all’11 settembre. Le 24 vincitrici sono state premiate per la loro capacità di creare innovazione a livello europeo nei loro settori di competenza, che per Pellegrini è quello della medicina rigenerativa. Osservatorio Terapie Avanzate ha colto l’occasione per intervistarla e approfondire le sue ricerche sulle terapie cellulari.
- Di: Rachele Mazzaracca
European Biotech Week 2020: raccontare le biotecnologie al grande pubblico
Una settimana di eventi in giro per il mondo e in Italia. Tra i temi trattati anche le terapie avanzate, con la partecipazione di Osservatorio Terapie Avanzate, e le terapie digitali
Dal 28 settembre al 4 ottobre si terrà la Biotech Week, un evento nato in Canada nel 2003, sbarcato in Europa nel 2013 e dedicato interamente alle biotecnologie, settore che vede molteplici applicazioni in altrettanti ambiti di ricerca. Tra questi c’è la biomedicina che, grazie alle recenti innovazioni scientifico-tecnologiche, offre nuove opportunità per il trattamento di gravi patologie ad oggi considerati incurabili, cambiando il significato di “medicina” e puntando sulla personalizzazione. La rivoluzione delle terapie avanzate e delle terapie digitali sarà illustrata il 28 settembre (dalle ore 15 alle 18) durante il webinar “Programmable Medicines and Digital Biotechnology”, organizzato da Da Vinci Digital Therapeutics e Argon Global Healthcare e a cui parteciperà Francesca Ceradini, Direttore Scientifico di Osservatorio Terapie Avanzate.
- Di: Redazione
Terapie avanzate: come si sta preparando l’Italia?
Un’alleanza permanente tra tutti gli stakeholder per garantire a tutti i pazienti italiani un accesso rapido ed omogeneo sul territorio. Se ne è parlato al webinar organizzato da ISS e Assobiotec
Attualmente sono dieci le terapie avanzate approvate in Europa, di cui cinque rimborsabili in Italia, ma l’obiettivo è quello di far crescere questo numero garantendo accesso e sostenibilità, temi molto discussi quando si parla di innovazione biomedica. E se ne è parlato anche lo scorso 15 settembre durante il webinar “Terapie Avanzate, il futuro è già qui: il sistema italiano è pronto a riceverle?”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Assobiotec Federchimica. Uno dei punti salienti è proprio quello del rapido accesso alle terapie avanzate per tutti i pazienti. Fondamentale per questo scopo è la creazione di una rete, di un’alleanza, tra istituzioni nazionali, regioni, società scientifiche, reti di centri ospedalieri e di ricerca, associazioni dei pazienti ed imprese biofarmaceutiche.
- Di: Redazione
Combattere l’Alzheimer. Tra terapie “classiche”, avanzate e una pandemia in corso
Oggi, giornata mondiale di questa grave patologia neurodegenerativa, è importante ricordare le terapie in arrivo e in via di sviluppo, ma anche il devastante impatto della COVID-19
Tra farmaci in fase di valutazione clinica, nuove strategie terapeutiche ancora in esplorazione - tra cui anche le terapie avanzate - e l’arrivo di biomarcatori che potrebbero permettere una diagnosi più accurata e precoce, la giornata mondiale per l’Alzheimer, che ogni anno si celebra il 21 settembre, potrebbe oggi essere accolta con un cauto ottimismo. Questo nonostante la pandemia COVID-19 e, in particolare, il lockdown abbiano avuto un impatto importante sul decorso della malattia, specie per i pazienti in fase iniziale e lieve/moderata. Come dimostra una recente indagine italiana in pubblicazione su Frontiers Psychiatry, condotta dal Gruppo di Studio sulla COVID-19 della Società Italiana di Neurologia per le demenze (SINdem).
- Di: Cristina Tognaccini